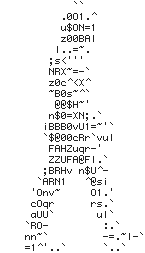Se nell'era digitale si scava una voragine (Corriere della Sera)
Riflessioni sulla memoria
Le innovazioni tecnologiche e la carta. Riflessione sulla capacità di salvaguardare il patrimonio della civiltà
Massimo Gaggi
Le foto di un reportage, tre anni fa in Alaska, sono andate perdute per la rottura dell’hard disk del mio computer. Quelle delle vacanze di due anni fa non le trovo più: finite in una memory card in fondo a qualche cassetto. Le immagini di dieci anni fa so perfettamente dove sono: in un vecchio floppy disk. Che i miei computer attuali non sono in grado di leggere. Le foto della mia prima vacanza — altopiano del Renon, 1957 — sono invece sempre lì: cartoncini appena ingialliti, tenuti insieme con un elastico in una scatola da scarpe.
La carta, rigida e costosa, viene sempre più spesso sostituita dalle tecnologie digitali: flessibili, economiche, a basso impatto ambientale e ingombro zero. È la storia che ci è passata sotto gli occhi, quella del ventennio dell’era dei computer, della crescita esponenziale delle informazioni disponibili (testi, immagini, video) e della possibilità di fruirle su uno schermo. Un’accelerazione che non potrà che crescere con la diffusione di strumenti come i telefonini «intelligenti» e, ora, gli ebook e l’iPad, appena messo in vendita dalla Apple negli Stati Uniti: la consacrazione della nuova epoca del supporto mobile ultrasottile e leggero, un po’ computer, un po’ giornale, un po’ tv e anche scaffale della libreria. La rivoluzione delle meraviglie digitali ha, però, anche cominciato a scavare una grossa voragine nella memoria dell’uomo. E non solo perché le nuove tecnologie cambiano i meccanismi dell’apprendimento e spingono verso percorsi di lettura più superficiali, continuamente interrotti dal ricorso ai link: coi nuovi supporti magnetici o elettronici, la conservazione delle informazioni per lunghi periodi di tempo si è rivelata un’impresa sorprendentemente ardua.
Non si tratta solo della perdita di dati o immagini, magari non essenziali, delle nostre vite private. Ormai, tra l’altro, le foto si possono archiviare anche in rete, se non ci si preoccupa troppo della privacy e della durata del servizio. «Tra l’altro nota Nicholas Carr, studioso dell’impatto della Internet culture sulle società contemporanee, «la crescente tendenza a trasferire i propri dati nelle cosiddette "nuvole digitali" senza più archiviarli in supporti di memoria personali crea una nuova vulnerabilità. Nella "cloud", infatti, tutto passa da un sistema di elaborazione di dati centralizzato. Che può essere sicuro e fruibile per un gran numero di anni. Oppure vulnerabile, esposto a incidenti tecnici, concepito con un orizzonte temporale limitato. Noi non lo sappiamo: siamo completamente nelle mani di chi gestisce il servizio».
Ma il problema della conservazione del patrimonio collettivo delle civiltà è ben più serio di quello dei nostri dati privati. Qui la desertificazione della memoria dilaga ovunque: i risultati dei censimenti Usa del periodo 1960-1980 sono andati in gran parte perduti, mentre il Pentagono non riesce più a recuperare i dati sull’uso di defolianti — l’agente «orange» — durante la guerra del Vietnam. Informazioni preziose per la ricerca e l’aggiornamento di alcune terapie mediche. La Nasa, poi, oltre a non avere più un programma spaziale degno di questo nome, sta diventando un cimitero di informazioni sepolte: i nastri sui quali sono stati registrati i dati dei voli spaziali degli Anni 70 sono inservibili da più di un decennio. Alcuni erano stati tradotti in formato digitale prima del loro decadimento, altri no. Ma anche gli apparecchi per la lettura dei nuovi formati, nel frattempo, sono divenuti obsoleti per la rapida evoluzione delle tecnologie elettroniche.
Il libro non ha bisogno di strumenti speciali per essere letto e, se la carta non contiene acidi, dura secoli: senza risalire alle incisioni su pietra e ai papiri dell’antico Egitto o alla Mesopotamia delle tavolette d’argilla vecchie di tremila anni che contengono il poema epico Gilgamesh, il volume di carta più antico, rinvenuto un secolo fa in una caverna della Cina, risale all’868 dopo Cristo. Sono numeri che fanno impallidire archivisti ed esperti della conservazione dei materiali che, alle prese con le tecnologie elettroniche, devono fronteggiare due ordini di problemi. Il primo riguarda il rapido deterioramento dei materiali: nastri magnetici di registratori audio e video, pellicole, floppy disk morbidi, hanno vita breve, dai cinque anni ai vent’anni. Cd e dvd si ritiene che possano durare, a seconda della qualità dei materiali usati, da venti a cento anni, ma nessuno ha idee chiare in proposito. La rottura dell’hard disk di un computer significa morte istantanea per tutte le informazioni che vi erano state immagazzinate. Il secondo nodo è quello della difficoltà di mantenere in efficienza strumenti elettronici ormai superati ma che sono gli unici in grado di leggere supporti (nastri, dischi, schede di memoria) non compatibili coi computer delle ultime generazioni.
Siamo ancora nell’infanzia dell’era digitale, ma le storie sono già molte: la manutenzione di centinaia di testate nucleari degli Anni 70 è costata al Pentagono 62 milioni di dollari più del previsto perché, per poter leggere manuali non disponibili su carta, è stato necessario ricostruire da zero apparecchiature analogiche che risalgono a due generazioni fa. Ci si è riusciti soltanto grazie alla disponibilità di qualche esperto di tecnologie ormai perdute, che ha accettato di interrompere la vita da pensionato per tornare al lavoro. La Nasa, racconta la rivista «New Scientist», ha vissuto una vicenda simile: aveva bisogno di recuperare i dati trasmessi negli Anni 60 dalle sonde Lunar Orbiter, ma non aveva più i lettori di nastri del tempo. Alla fine ne ha trovato uno nella cantina di un suo ex dipendente: era diventato la tana di una lucertola. Restaurarlo e imparare di nuovo a usarlo è stata un’impresa. Problemi che riguardano la scienza, ma anche la conservazione di tutti gli altri aspetti della nostra civiltà, dalla letteratura alla storia. L’Archivio nazionale di Washington ha investito una cifra enorme per evitare che 11 mila ore di registrazioni di testimonianze di criminali nazisti al processo di Norimberga — a partire dal racconto del dottor Mengele dei suoi esperimenti su cavie umane — andassero perdute. Anche qui è stato necessario ricostruire un Recordgraph, strumento col quale, negli Anni 40, venivano letti rudimentali nastri di plastica.
Anche la letteratura comincia ad avere i suoi problemi. Salman Rushdie sta esponendo alla Emory University di Atlanta il suo materiale d’archivio: libri, manoscritti, giornali e quattro computer Apple. Un «giacimento» digitale di 18 gigabyte, la cui esplorazione, però, già presenta grossi problemi tecnici. E sì che Rushdie ha cominciato a usare la scrittura elettronica solo 21 anni fa, quando la fatwa dell’ayatollah Khomeini lo costrinse a vivere nascosto. Quello dello scrittore anglo-indiano è solo il primo di una serie di casi destinati a diventare l’incubo di bibliotecari e archivisti di tutto il mondo: tre settimane fa l’Harry Ransom Center della Texas University ha annunciato di aver acquistato gli archivi digitali di David Foster Wallace, lo scrittore morto suicida nel 2008. A sua volta la Houghton Library di Harvard sta cercando di capire come utilizzare i 50 vecchi floppy disk ricevuti da John Updike poco prima della sua scomparsa. Leslie Morris, curatore della Houghton, ha spiegato al «New York Times» che la biblioteca non dispone della metodologia né delle risorse per «processare» questi supporti digitali: «Per ora ci limitiamo a conservarli in un ambiente con temperatura e umidità controllate». E Anne Van Camp, direttrice degli archivi della Smithsonian Institution, confessa allo stesso quotidiano di non dormirci la notte: tocca a lei, insieme ad altri esperti incaricati dalla National Science Foundation, cercare una risposta tecnicamente ed economicamente praticabile al dilemma della «digital preservation».
Mentre le riviste scientifiche di mezzo mondo immaginano scenari apocalittici — il mondo semidistrutto da guerre o cataclismi naturali con i superstiti che non riescono a ricostruire le conoscenze della nostra civiltà perché privi degli strumenti di lettura di ciò che resta degli archivi elettronici — commissioni governative, National Archives (che hanno investito 308 milioni di dollari nell’impresa) e fondazioni private cercano risposte per uno dei dilemmi più sorprendenti e sottostimati del nostro tempo. Le questioni sono tecniche ma anche economiche: la carta rimane l’unico standard certamente capace di durare nel tempo, mentre le rivoluzioni tecnologiche rendono rapidamente obsolete tutte le nuove macchine che arrivano sul mercato. E quando uno standard di lettura non è più considerato efficiente viene spazzato via: ingegneri e «softwaristi» hanno il culto dell’efficienza. La loro attenzione è tutta concentrata sull’immediato, sull’equazione «più veloce, meno costoso». «Quello dell’eternità» — sintetizza il «New Scientist» — «non è considerato un mercato interessante». Il timore, diffuso tra gli intellettuali, di perdere la memoria per effetto dell’avvento di una nuova era delle macchine che rivoluziona i meccanismi dell’apprendimento e anche quelli dell’archiviazione fisica ha ispirato lo scrittore di fantascienza Neal Stephenson che in Anathem, il suo ultimo romanzo, racconta la storia di una comunità di scienziati trapiantata sul pianeta Arbre. Uomini che, per sfuggire a una civiltà elettronica che atrofizza le capacità mnemoniche e spinge a ragionare con una logica di breve periodo, decidono di rinchiudersi in una specie di convento privo di computer dove tutti i calcoli vengono fatti a mano, su fogli di una carta capace di durare millenni. Un luogo nel quale si lavora solo su progetti privi di scadenza e nel quale l’unico motore di ricerca è la capacità di archiviazione della propria mente, quotidianamente allenata ad ampliare i confini del sapere immagazzinato.
Un romanzo visionario, metafora di una contemporaneità contrassegnata dalla diffusione dell’attention deficit disorder (la difficoltà che molti, soprattutto i giovani, incontrano nel concentrarsi). Più di uno spunto, Stephenson lo ha trovato in una curiosa iniziativa, quella della Long Now Foundation (Fondazione del lungo presente): un’associazione filantropica di intellettuali — dal musicista Brian Eno al «computer scientist» Danny Hillis — che credono nel valore della tecnologia, ma vogliono anche contrastare il diffondersi della logica dello short term, del risultato immediato, da loro vista come una sorta di «sottocultura digitale». L’iniziativa più nota della fondazione, il cui obiettivo è seminare iniziative culturali che «guardano lontano», è il piano per la costruzione di un orologio meccanico capace di funzionare per diecimila anni quasi senza interventi umani, alimentato da pochissima energia, robusto e basato su componenti di basso valore in modo da ridurre il rischio di furti o di distruzione in qualche calamità naturale o provocata dall’uomo. Un piccolo prototipo è stato realizzato una decina d’anni fa ed è attualmente in funzione in un museo inglese. L’orologio millenario vero e proprio, una specie di cattedrale della meccanica, verrà, invece, costruito nei prossimi anni in un località del Nevada.
A progettarlo è stato lo stesso Hillis, scienziato informatico che ha speso la sua vita nello sviluppo di quella che il massmediologo Derrick De Kerckhove chiama la «fase cognitiva dell’era elettrica». Ma che è anche consapevole della fragilità delle tecnologie digitali e della necessità di assicurarsi contro il rischio di blackout o di improvvise ondate «controrivoluzionarie». La Long Now, comunque, ha in cantiere anche programmi dal valore più pratico come «Rosetta Project»: la realizzazione di dischi di nickel capaci di durare centinaia, forse migliaia di anni, ognuno dei quali, attraverso una tecnica di microincisioni, può contenere fino a 30 mila pagine di testo. È questa la via giusta per garantire che l’umanità, trasformando i suoi archivi cartacei in una sterminata biblioteca digitale come quella sognata dai fondatori di Google, non rischi di passare repentinamente da «tutta la conoscenza dell’universo a portata di click» all’improvvisa oscurità di un mondo che smarrisce la memoria? Difficile individuare una soluzione tecnica affidabile, rinunciare a ogni back up su carta. Di certo tutte le soluzioni allo studio hanno costi elevati e pongono il problema di quale sia, nella babele degli scritti e delle immagini, la conoscenza del mondo che merita di essere salvata.
Meglio, comunque, questi dilemmi che addentrarsi a cuor leggero, con l’ottimismo del tecno-utopista, in un mondo nel quale — come spiega Michael Olson, project manager degli archivi digitali dell’università di Stanford — gli unici a sapersi orientare tra dischetti, flash card, cd, dvd, vecchi e nuovi computer, sono i reparti specializzati della polizia investigativa. Dall’ottimismo di chi spera nella diffusione di una conoscenza universale e democratica ai saperi affidati a un «apriscatole» giudiziario.
Massimo Gaggi
http://www.corriere.it/cultura/10_aprile_04/memoria-era-digitale-scava-voragine_4dc400cc-3fc9-11df-8d90-00144f02aabe.shtml